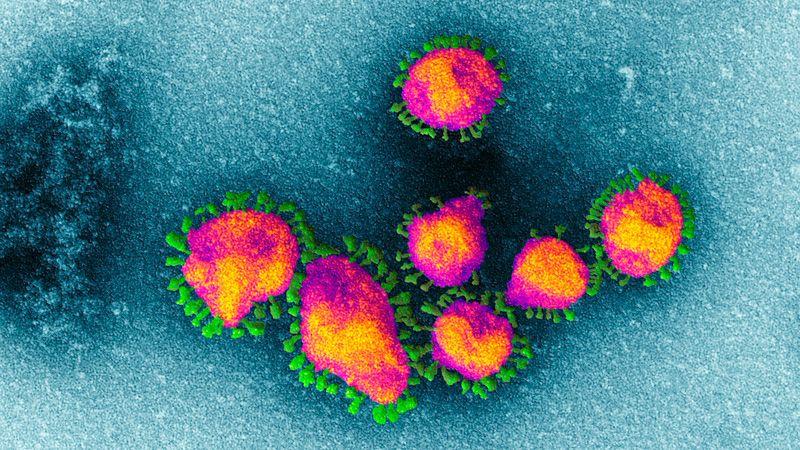Sono passati quasi due mesi dalla rilevazione in Italia dei primi casi di SARS-CoV-2 e da allora l’attività scientifica internazionale, incentrata verso questa nuova patologia, ha visto il succedersi di dati ed evidenze a volte contrastanti, che (grazie anche all’incontrollato tam-tam mediatico) hanno talvolta generato confusione nei non addetti ai lavori.
Con lo scopo di descrivere e diffondere le più recenti evidenze scientifiche emerse, proviamo a fare luce su alcuni temi sanitari di estremo rilievo, degni nell’ultimo periodo di grande risonanza mediatica.
Dati italiani sulla letalità: perché è cosi alta?
Uno dei temi più caldi e ancora dibattuti: perché la letalità italiana sembra assestarsi a più del 9% mentre in Cina è ferma al 3.8%? E come si spiega la differenza verso gli altri Paesi?
Due i fattori principali da tenere in conto per fotografare adeguatamente la situazione italiana: l’età media elevata del nostro Paese rispetto alla Cina (e alla media europea) e il numero verosimilmente sottostimato dei soggetti realmente contagiati dal SARS-CoV-2. All’incremento dell’età corrisponde infatti l’aumento della possibilità di essere affetti da altre patologie (le cosiddette “comorbilità”) e quindi la suscettibilità a contrarre l’infezione. Per fare un confronto è utile evidenziare come la fascia d’età interessata in Italia dal maggior numero dei decessi (quella dei soggetti con almeno 80 anni) è responsabile in Cina solamente del 3% dei contagi totali. Non meno importante la precisazione riguardante la definizione di letalità della malattia, calcolata dividendo il numero dei decessi dovuti alla malattia per i casi identificati della stessa. L’Italia, seguendo le direttive OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), ha iniziato un’intensa attività di valutazione dei soggetti già sintomatici, escludendo quindi dal conto l’alta percentuale di soggetti affetti da COVID-19 con lieve o scarsa sintomatologia, finendo probabilmente per sottostimare il numero reale dei contagiati. Negli ultimi giorni è in corso di valutazione presso il Ministero della Salute l’opportunità di estendere il test a tutti i contatti dei pazienti risultati positivi, con lo scopo di rintracciare (e dunque monitorare adeguatamente) il più alto numero di soggetti affetti.
I test per la diagnosi
Dall’inizio dell’epidemia sono al vaglio dell’OMS circa 200 test rapidi per la diagnosi di COVID-19.
Si fa spesso menzione del test anticorpale (per la ricerca di IgM e IgG specifiche del virus) eseguibile su siero, che però attualmente non è in grado di fornire risultati rapidi (e talvolta attendibili) per la diagnosi di infezione da Sars-Cov-2. Attualmente l’unico test che consente di fare diagnosi certa della malattia è quello che ricerca la presenza del genoma virale (attraverso la tecnica chiamata rt-PCR, ovvero reverse trascription polimerase chain reaction) nelle secrezioni respiratorie dei soggetti infetti. Ciò che rende inattuabile al momento uno screening “a tappeto” della popolazione (perseguendo il modello coreano) è l’alto costo dei reagenti per l’effettuazione del test e i tempi richiesti dai pochi laboratori di riferimento presenti sul territorio per l’analisi di una così grande quantità di tamponi.
In queste ore, la FDA (Agenzia americana del farmaco) sembra aver annunciato l’adozione di un nuovo test rapido sviluppato da un’azienda italiana che consentirà di abbattere il tempo di risposta da 6-7 ore a 60 minuti. I primi a beneficiare del test dovrebbero essere gli ospedali e le strutture di triage delle regioni italiane più colpite.
Farmaci (1) e il rischio di contagio: gli antipertensivi
Alcuni autori hanno ipotizzato un legame tra l’aumento della probabilità di contagio da SARS-CoV-2 e l’uso di alcuni farmaci antipertensivi (come ACE-inibitori e sartani), in quanto le proteine che il virus utilizzerebbe per entrare nell’organismo possono risultare incrementate dall’utilizzo costante di questi farmaci. La notizia, rimbalzata sui social media, ha creato grande preoccupazione nei tantissimi utilizzatori abituali, costringendo l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) e la Società Europea di Cardiologia all’emissione di una nota ufficiale che ne raccomandasse fermamente la prosecuzione. Ad oggi infatti non solo non esistono studi sugli animali che confermino l’azzardata ipotesi, ma sembra invece come queste specifiche classi di antipertensivi svolgano un ruolo protettivo verso le possibili complicanze polmonari.
Farmaci (2): l’intuizione del Tocilizumab
Nonostante non ci sia ancora una terapia standard per curare i pazienti affetti da COVID-19, la comunità medico-scientifica si è adoperata molto negli ultimi mesi per comprendere i maccanismi con cui la malattia evolve e danneggia l’organismo degli individui contagiati. Gli studi condotti durante la precedente esperienza cinese hanno evidenziato come un’eccessiva risposta del sistema immunitario (conseguente all’infezione) possa determinare un gravissimo danno polmonare e come alcuni farmaci antinfiammatori fossero invece in grado di limitarne l’estensione.
Il Tocilizumab in particolare, un farmaco utilizzato negli ultimi anni per patologie infiammatorie e oncologiche, si è dimostrato in grado di limitare i danni dell’infezione da coronavirus (attraverso la sua azione sul recettore dell’interleuchina-6, un mediatore dell’infiammazione) in uno studio condotto in Cina lo scorso febbraio, preliminare al primo vero Trial clinico effettuato su 188 pazienti. Sulla base di questa esperienza, l’istituto Nazionale Tumori “Fondazione Pascale” di Napoli, in collaborazione con e medici e ricercatori cinesi e italiani, ha avuto il merito di ideare e promuovere il protocollo per la sperimentazione italiana del Tocilizumab nel trattamento della polmonite da COVID-19 (studio TOCIVID-19) a cui potranno partecipare tutti i centri italiani che ne facciano domanda.
Gravidanza e COVID-19
Ha destato subito grande preoccupazione l’eventualità di un contagio durante il periodo della gravidanza, anche in considerazione dei numerosi eventi avversi riportati (soprattutto nel primo trimestre di gravidanza) per alcuni coronavirus correlati (SARS-CoV e MERS-coV).
I dati presenti in letteratura per il SARS-CoV-2, seppur limitati, non hanno fatto emergere casi di infezione intrauterina, rendendo attualmente improbabile l’ipotesi che il virus possa avere effetti sullo sviluppo fetale nella determinazione di difetti congeniti. Il virus, inoltre, non è stato mai rilevato nel liquido amniotico.
Anche l’allattamento non viene controindicato, poiché sono in aumento gli studi che confermano l’assenza della trasmissione virale attraverso il latte materno. Consigliata naturalmente anche per le donne in gravidanza l’adozione delle normali azioni preventive per ridurre il rischio di infezione, come lavarsi spesso le mani ed evitare contatti con persone malate. Come ulteriore precauzione, ricercatori autorevoli hanno recentemente raccomandato nelle donne contagiate una valutazione ecografica bimestrale, allo scopo di escludere eventuali difetti di crescita intrauterina.
Coronavirus: sopravvivenza sulle superfici
La rapida diffusione del contagio ha portato i ricercatori a chiedersi quanto il coronavirus fosse effettivamente in grado di resistere su alcune delle superfici più comuni e a ricostruire in laboratorio (attraverso nebulizzatori che simulassero colpi di tosse e starnuti) le modalità con cui il virus può depositarsi nell’ambiente domestico. Dati preliminari sono stati forniti da ricercatori americani che hanno evidenziato come, nonostante l’evidenza di una netta diminuzione della carica virale col passare delle ore, il SARS-CoV-2 resista su plastica e acciaio fino a tre giorni, venendo rilevato sul cartone fino a 24 ore (similmente a quanto già visto con i precedenti coronavirus).
La buona notizia è che l’utilizzo di semplici disinfettanti a base di cloro o contenenti alcol sono risultati in grado di eliminare il virus e annullare la sua capacità di infettare le persone. Assume dunque particolare importanza la permanenza al domicilio (per limitare il numero di superfici con cui veniamo a contatto) e l’igiene frequente degli oggetti e delle superfici più spesso utilizzati.
Mascherine protettive: come usarle?
L’organizzazione mondiale della sanità (OMS) consiglia l’uso delle mascherine chirurgiche solo a chi presenti sintomi suggestivi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, febbre e starnuti) o si prenda cura di un sospetto contagio. Le mascherine verdi chirurgiche, infatti, sono un dispositivo che protegge soprattutto gli altri dal possibile contagio, in quanto limita la dispersione delle particelle di saliva di chi le indossa. In un contesto come quello italiano di notevole diffusione della malattia, può comunque avere senso indossarle ad esempio ogni volta che si esce per fare la spesa (in aggiunta all’osservazione della corretta distanza di sicurezza dalle altre persone), in quanto limita inoltre la possibile diffusione del virus nell’ambiente attraverso le nostre secrezioni. Di primaria importanza una corretta igiene delle mani sia prima del posizionamento della mascherina (che deve aderire bene al volto coprendo naso e bocca), sia dopo, al momento della rimozione, che deve avvenire attraverso l’elastico e senza la manipolazione della parte anteriore (“sporca”).
Ultimo appunto sulle mascherine dotate di valvola, con la sigla FFP (particulate filtering Facepiece, ovvero maschera filtrante particelle): tali dispositivi sono al momento necessari (e ancora in numero insufficiente) agli operatori sanitari, in quanto proteggono chi le indossa dagli aerosol derivanti dalle secrezioni degli affetti da SARS-CoV-2 e dalle procedure invasive a cui essi sono sottoposti. Pertanto, per la loro unidirezionalità dovuta alla valvola, costituiscono da filtro solo in entrata, contribuendo potenzialmente a diffondere il contagio di chi è malato.